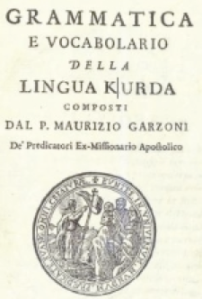Europa, Schengen e ipocrisie
May 14, 2011 1 Comment
Un Consiglio straordinario dei ministri degli Interni dell’Unione si è ieri per discutere del trattato Schengen, firmato nel 1985 e entrato in vigore a partire dal 1995. Questo trattato, che porta ormai i suoi anni sulle spalle, è stato messo in discussione recentemente a seguito del battibecco tra Francia e Italia a causa dei cittadini tunisini che hanno raggiunto in grande numero l’Italia a seguito dei disordini in Nord-Africa.

Der Standard – Vienna – Oliver Schopf
Il trattato Schengen prevede la libera mobilità dei cittadini all’interno degli stati firmatari. Tanto per farla chiara, il trattato è quello che ci permette di andarcene tranquillamente in Francia, Germania, Austria, Slovenia e da lì altrove senza neanche doverci fermare alla frontiera né esibire il passaporto o la carta d’identità in treno. È all’interno dello stesso trattato che si prevede la libera circolazione non solo dei cittadini degli stati membri, ma anche di quei cittadini che, provenienti da altri paesi altri, ottengano un visto.
E’ stato questo principio a essere stato messo in discussione da Sarkozy, che si è rifiutato di accettare i cittadini immigrati tunisini che avevano ricevuto un visto provvisorio dall’Italia. Le forze dell’ordine hanno letteralmente fermato queste persone a Ventimiglia, impedendo loro di passare il confine.
Così facendo, Francia e Italia hanno messo in crisi l’intera Unione Europea e il trattato che vige ormai da diversi anni tra gli stati dell’area Schengen. Molti hanno criticato la scelta del governo Italiano di rilasciare i permessi di soggiorno. Cosa doveva fare? Se i centri di accoglienza – giusto per chiamarli con un nome carino eh – erano già stracolmi e già erano stati istituiti delle tendopoli temporanee? Lasciare i tunisini girare senza permesso di soggiorno, perciò rendendoli illegali?
Sicuramente la nostra burocrazia non è delle migliori, ma in una situazione di emergenza di questo tipo non è tanto facile criticare.
Sia Berlusconi che Napolitano hanno invocato l’aiuto dell’Unione Europea fin dall’inizio degli sbarchi che hanno seguito le rivolte nel mondo arabo, senza ricevere alcuna risposta. Al rilascio dei permessi di soggiorno temporanei per gli arrivati, la Francia ha accusato l’Italia di aver violato l’ideologia del trattato di Schengen, permettendo – ipoteticamente – agli immigrati di spostarsi liberamente all’interno dell’area Schengen.
Il polverone sollevato da Sarkozy ha avuto seguito, considerato il generale spirito anti-europeo del momento, alimentato dalla crisi in Grecia e dai fallimenti della politica economica dell’Unione Europea. Analisti, giornalisti e politici sono tornati ad interrogarsi sulle funzioni ed efficacia dell’Unione.
La Danimarca non ha perso tempo, dichiarando l’11 di Maggio che ristabilirà controlli sui suoi confini con la Germania e Svezia.
Questo è un grande segno di debolezza, che rischia davvero di mettere in crisi lunghi anni di lavoro e di cooperazione. Se davvero si dovessero rimettere in discussione i trattati Schengen e ristabilire i confini tra i paesi firmatari, potrebbe davvero essere un grande passo indietro, nonché segno di rassegnazione anche alle pressioni dell’elettorato xenofobo.
I vertici europei potrebbero d’altro canto agire diversamente e iniziare un dialogo serio e produttivo per progettare un sistema comune di controllo dei confini esterni. Ad oggi infatti i criteri di rilascio di visti e di concessione di asilo politico cambiano enormemente da stato a stato, senza contare la differenza di posizione geografica e perciò di gestione dell’immigrazione illegale.
Tornare indietro significherebbe davvero dimostrare il fallimento del progetto Europeo, che ci hanno propinato in ogni salsa negli ultimi 20 anni. Significherebbe anche un tradimento di noi elettori e cittadini, trattati come pedine che si vedono tracciare e cancellare confini.